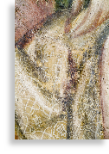La "Madonna del Ricamo" di vitale: Storia di un "Filo" di Rosa D'Amico e Camillo Tarozzi - vitale
Menu principale:
- Home Page
- cronologia
-
Le Madonne
- introduzione
- Madonna operosa
- Madonna regale
- devozioni private
- I polittici
- Affreschi
-
Madonna del Ricamo
- home page
- introduzione
- Rilievo tattile
- Storia di un "Filo"
- La tecnica pittorica
- Iconografia
La "Madonna del Ricamo" di vitale: Storia di un "Filo" di Rosa D'Amico e Camillo Tarozzi



Vicenda storica dell'affresco e suo inserimento nel percorso della pittura di Vitale da Bologna
L'attribuzione e la datazione
Il riconoscimento del dipinto costituì straordinaria acquisizione alla conoscenza della pittura bolognese del Trecento, sia dal punto di vista storico-
La composizione ripropone un'immagine apparentemente consueta: racchiusa entro una cornice ad elementi romboidali, solo in piccola parte conservata, la Madonna vi è seduta su un cuscino, che sporge appena lungo il margine sinistro. Accanto a lei, sull'altro lato, è il piccolo Gesù, già cresciuto, che con una mano le afferra un lembo del manto, quasi a volerne attirare l'attenzione, mentre con l'altra indica verso il basso, in una direzione nella quale nella immagine più ampia doveva in origine comparire almeno un altro personaggio.
La Vergine, con la testa appena chinata verso il Figlio, lo guarda con tenerezza che ancor oggi non ha bisogno di aggettivi per essere compiutamente compresa. Le figure si stagliano contro il fondo del cielo, su cui, in alto, sono ancora presenti le tracce di alcune delle stelle d'oro che in origine ne ornavano più diffusamente il letto di lapislazzuli, che ora possiamo solo evocare. Raggi dorati, di cui resta solo qualche segno ad indicarne l'esistenza, dovevano circondare la figura della Vergine, a sottolinearne la sacralità. Sul suo grembo, tra lei e il Figlio, è ben visibile un tessuto chiaro, riccamente decorato a losanghe incrociate con motivi in bianco.
L'opera non è firmata ma è come se lo fosse: in essa infatti fu presto identificata tutta la sapienza pittorica di Vitale da Bologna, uno dei protagonisti delle tendenze artistiche che si affermarono in città nella prima metà del '300. Già nell'impostazione generale della composizione, basata sul movimento espressivo e naturale, può individuarsi una delle chiavi di lettura che ne collegano l'esecuzione all'attività del maestro. Come già si ricordava nella prima pubblicazione dell'affresco (2), bambini vispi e cresciuti, che stanno, come qui, ritti da soli o accoccolati sul fianco e non in braccio alla Madonna, tornano più di una volta nella sua produzione. In questo caso il piccolo addirittura si arrampica sul fianco della Madre con uno scatto improvviso e con un gesto indicatore della mano: si era supposto che quel gesto lo rendesse immediato ed efficace intercessore a favore di uno sconosciuto donatore da immaginare in basso a destra, dove l'affresco si interrompe, o in alternativa, che l'indice fosse rivolto ad un'altra figura di significato simbolico del quale non è ancor oggi possibile identificare un riferimento iconografico.
Profondo e vero è il rapporto psicologico tra la Madre ed il Figlio. Il Bambino si tende per afferrare il manto della Vergine: lei si ritrae con un'intensità tutta incentrata nel cerchio affettivo che lega le due figure e nel lampeggiare degli sguardi il cui incontrarsi, morbido e affettuoso, rivela quell'interesse per il naturale e l'umano che sempre caratterizzò l'opera dell'artista, ma che qui è davvero ancora più profondamente presente rispetto ad altre testimonianze note della sua produzione.
Nella basilica di San Francesco, dove il dipinto si trovava prima del 1801, la presenza del giovane Vitale, come già sottolineava sensibilmente Cesare Gnudi (3) dovette essere particolarmente significativa: nel complesso egli era stato attivo almeno dal 1330, data cui un documento fa risalire gli affreschi perduti eseguiti da un 'Vindalinus', con lui identificato, in una cappella di cui era allora patrono Filippo degli Odofredi. Tanto più l'acquisizione di questa Madonna al patrimonio francescano si rivelò subito di interesse straordinario: l'opera costituiva in effetti l'unica sopravvivenza riconosciuta al maestro nel complesso insieme al Cenacolo tra Santi, 'strappato' nel 1935 dalla parete di uno dei locali dello stesso convento e ora esposto nella Pinacoteca Nazionale di Bologna (4) .
Attribuita nei primi studi agli anni quaranta del '300 ed accostata ad opere già note della maturità di Vitale, come la Madonna dei Denti e il Presepe già nella controfacciata della chiesetta di Mezzaratta (5) , di lì a poco si arrivò ad arretrarne l'esecuzione, spostandola al decennio precedente. A partire dall'andamento della composizione, più accentuatamente gotica rispetto ai modi riconoscibili nella produzione successiva dell'artista, numerosi sono in effetti già gli elementi di stile che fanno propendere per un suo inserimento nell'attività giovanile, e la collegano alla circolazione culturale della prima metà del secolo. La proposta datazione, ben addietro negli anni trenta del Trecento (6), trovò motivi di convalida nel rapporto con testimonianze in genere legate alla prima maturità del maestro in quello stesso quarto decennio: e proprio le riscontrate affinità con la Madonna già in San Francesco hanno portato ad anticipare anche il citato Cenacolo tra santi, dipinto da Vitale nel locale dello stesso convento che in origine era forse il Refettorio della Foresteria, destinato agli ospiti e ai visitatori (7).

Tecnica pittorica